Questa è la pagina dedicata a Lucio Russo.
In questa pagina troverai 5 prodotti, tra cui “Il tracollo culturale. La conquista romana del Mediterraneo (146-145 a.C.)”.
La rivoluzione dimenticata: Il pensiero scientifico greco e la scienza moderna. Nuova edizione completamente rivista
Il tracollo culturale. La conquista romana del Mediterraneo (146-145 a.C.)
Il biennio 146-145 a.C. costituisce uno spartiacque in genere non considerato della storia del mondo mediterraneo: in quegli anni Roma si impadronì di fatto di tutto il Mediterraneo, distruggendo Cartagine, sottomettendo la Grecia e riducendo Egitto e Siria a stati fantoccio alle sue dipendenze. L’espansione del potere di Roma si accompagnò a un grave regresso culturale, finora largamente ignorato, che viene qui illustrato nei suoi vari aspetti: il crollo della scienza, la fine delle ricerche filosofiche e linguistiche, la profonda trasformazione della tecnologia, che recise ogni legame con la scienza e la cultura scritta, e la drastica riduzione delle conoscenze geografiche. Il volume mostra come quel tracollo e l’oblio che lo ha avvolto abbiano fortemente condizionato tutta la successiva cultura occidentale fino a oggi.
Perché la cultura classica. La risposta di un non classicista
Qual è il valore che oggi viene attribuito alla cultura classica? è vero, come sostengono in molti, che lo studio del greco antico e del latino sarebbe ormai del tutto inutile nelle società moderne, marcatamente orientate verso discipline e conoscenze di immediata utilità, e che il liceo classico dovrebbe essere abolito? Per molti secoli, dal Rinascimento ad almeno tutto l’Ottocento, le fonti classiche hanno svolto un ruolo chiave all’interno del pensiero europeo, come è testimoniato dai numerosissimi debiti linguistici di parecchie scienze nei confronti del greco antico. Per non parlare di concetti che sono considerati fondamentali per la nostra civiltà, come quelli di «contratto sociale» e «democrazia», attinti dalla cultura greca. Poi c’è stato uno strappo. Nel corso del Novecento la conoscenza del mondo classico si è via via indebolita, fin quasi a scomparire dagli studi superiori, soppiantata da un’evoluzione della cultura verso una collezione di saperi disgiunti che sembrano aver dimenticato le radici comuni, al punto da indulgere a derive irrazionalistiche. Lucio Russo in questo saggio mostra con una vasta gamma di esempi come il debito dell’Occidente verso le civiltà greca e romana sia di gran lunga superiore a quello usualmente riconosciuto, perché ha riguardato tutti gli aspetti della cultura e non solo – come vorrebbe un diffuso luogo comune – quelli oggi classificati come «umanistici» (pensiero politico, diritto, filosofia, arte, musica e letteratura). Spaziando dall’astronomia alla fisica, dalla geometria alla matematica, dalla geografia all’ottica, l’autore chiarisce infatti in modo inoppugnabile come la scienza europea abbia mutuato i suoi fondamenti epistemologici – i metodi dimostrativo e sperimentale – dallo studio dei pochi trattati ellenistici che ci sono pervenuti, in particolare le opere di Archimede e gli Elementi di Euclide. «La tesi principale del libro» scrive Russo «è che la cultura classica, se profondamente rivisitata, potrebbe assumere di nuovo, pur se in modo diverso, quel ruolo unificante svolto in passato e per il quale non è mai stato trovato un valido sostituto.»
Opinioni:
Che cosa l’antichità greca e latina ci ha dato e che cosa può ancora darci. – LaFeltrinelli
Euclide: il primo libro degli Elementi. Una nuova lettura
Gli Elementi di Euclide hanno costituito per più di due millenni il testo base dell’insegnamento scientifico. Già il titolo mostra come l’autore intendesse esporre conoscenze basilari, fornendo gli strumenti utili per raggiungere risultati più avanzati. La geometria – il principale argomento dell’opera – era infatti la base di tutta la scienza esatta dell’epoca e i problemi di astronomia, ottica, meccanica, idrostatica, geografia matematica, topografia e così via venivano risolti disegnandone la soluzione. Il i libro degli Elementi è qui ricostruito eliminandone alcuni brani, individuati come spuri per la loro incongruenza logica/con il contesto. Ne è risultato un teéto più coerente e didatticamente efficace di quello trasmesso dalla tradizione manoscritta, il cui studio può fornire ancora oggi una preziosa guida metodologica.
Archimede. Un grande scienziato antico
Ci sono giunte diverse opere di Archimede, ma solo pochi specialisti le leggono. Alcuni suoi risultati, come il calcolo del volume della sfera o il famoso principio di idrostatica, sono insegnati a scuola, ma senza accennare al modo in cui Archimede li aveva ottenuti. Il pensiero del principale esponente della scienza ellenistica continua così a essere ignorato anche da classicisti e scienziati, mentre la sua fama presso il pubblico è affidata solo al ricordo di alcuni aneddoti leggendari. L’analisi critica degli episodi trasmessi dalla tradizione è qui accompagnata dall’esposizione di una parte consistente dei risultati di Archimede, sufficiente per vedere all’opera il suo metodo scientifico, mostrandone la potenza e l’eleganza. La sua scienza era profondamente unitaria: non conosceva l’attuale distinzione tra matematica e fisica, univa strettamente il rigore dei ragionamenti all’intuizione visiva e permetteva a un singolo scienziato di controllarne tutti gli aspetti, dalla scelta dei postulati alle applicazioni tecnologiche. Il suo studio ha un grande interesse epistemologico e didattico e può dare un significativo contributo alla ricostruzione dell’unità della cultura.
Se volessi saperne di più, dai un’occhiata al nostro canale Youtube!
- Porta agende Migliori, i più belli e consigliati
- Milena Colombo Libri Migliori da leggere e consigliati
- Vanni Iori Libri Migliori da leggere e consigliati
- Capire l’inglese parlato nei Film e Serie TV | Come fare a capire l’inglese parlato velocemente
- Migliori Libri di Grazia Deledda | Romanzi Grazia Deledda Consigliati









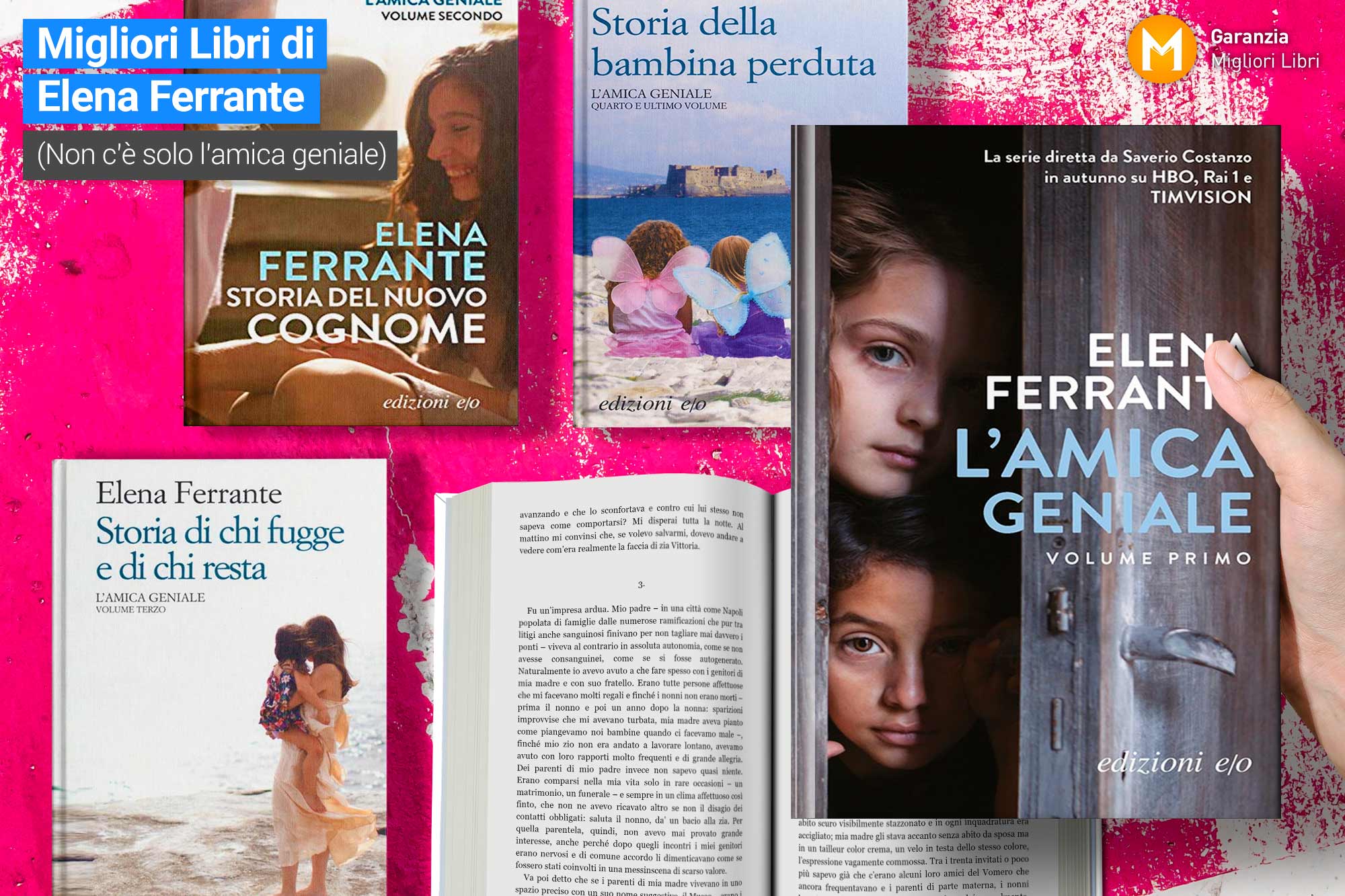

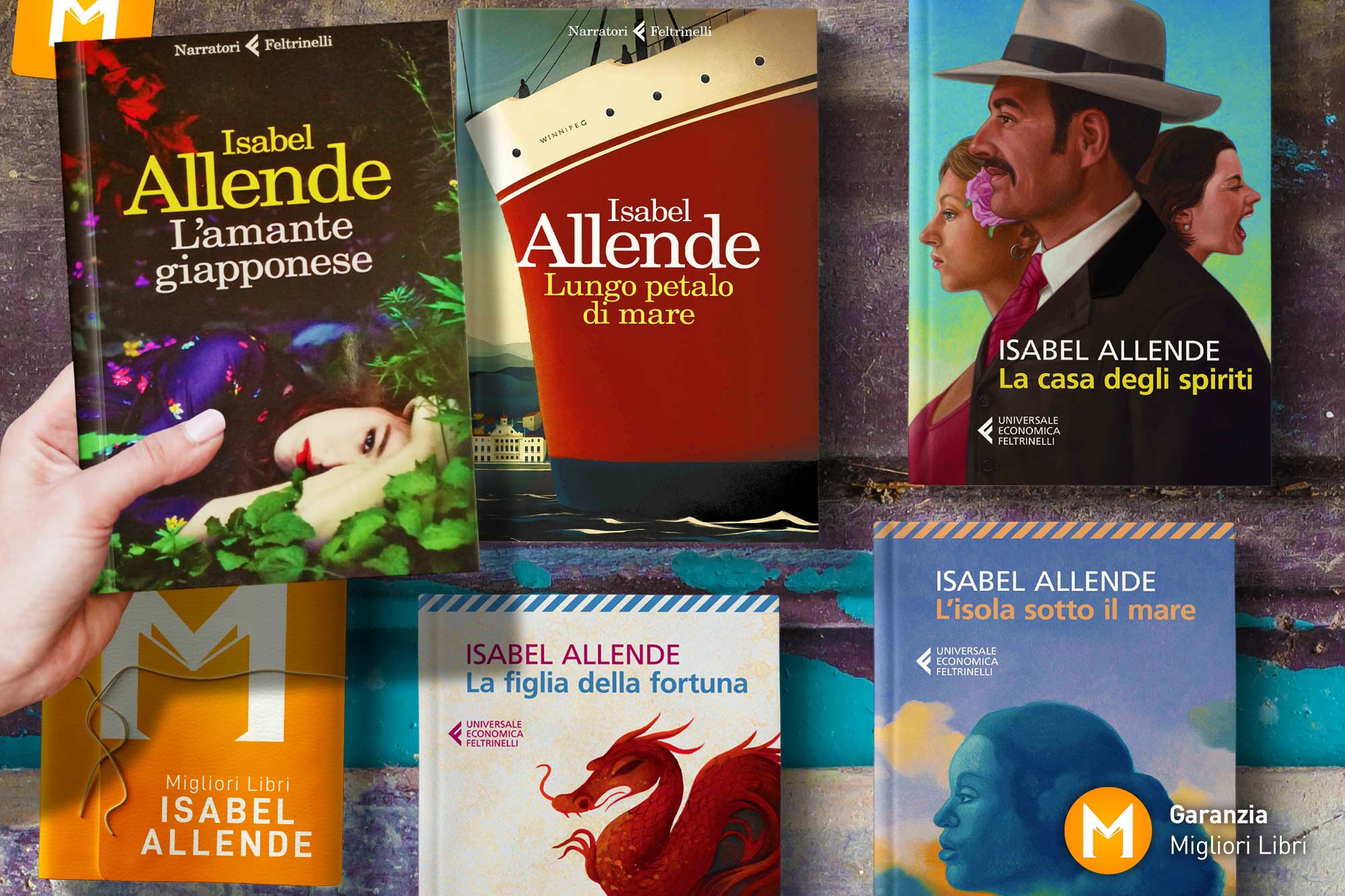


Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.